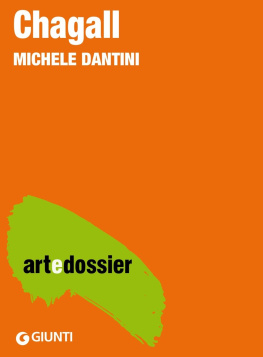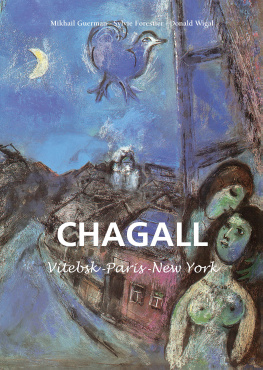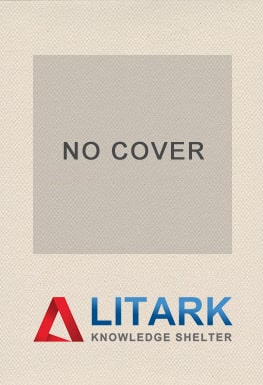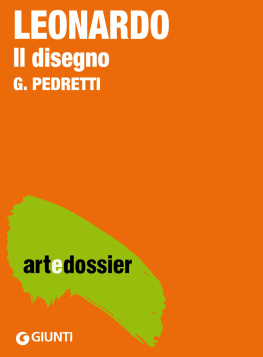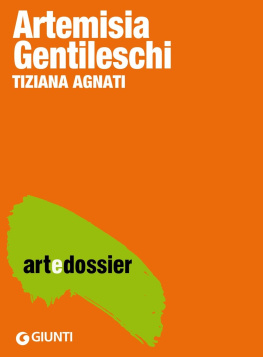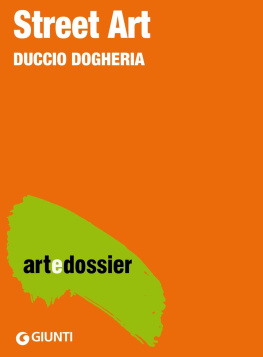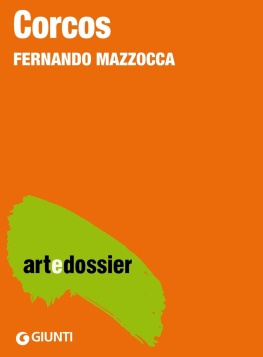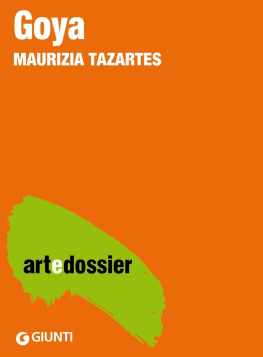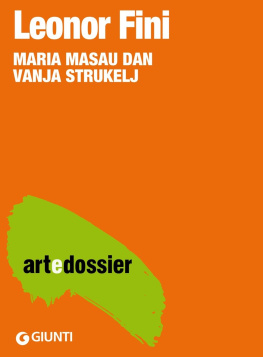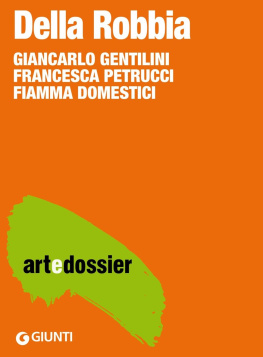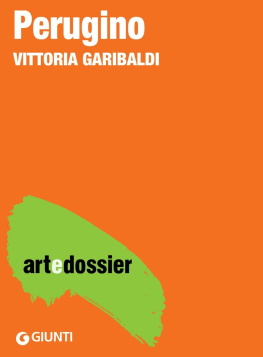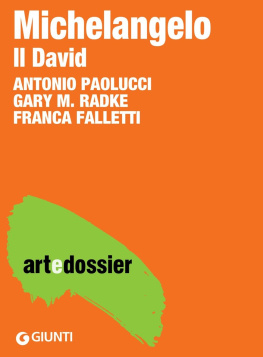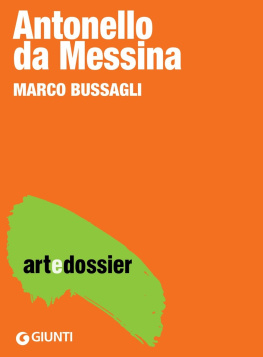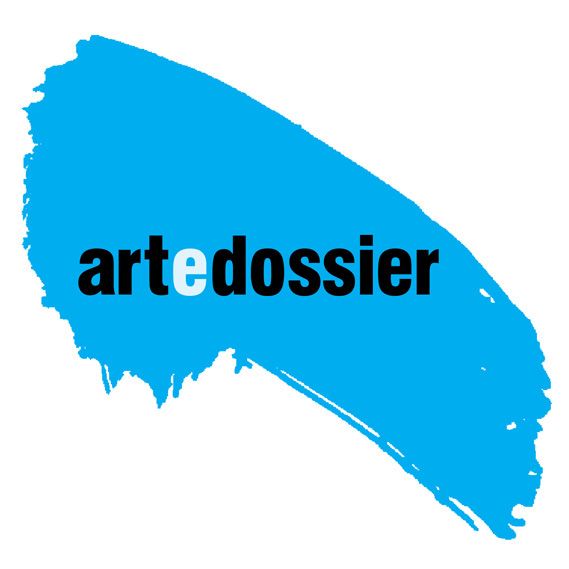2014 Giunti Editore S.p.A.
UNA STUDIATA INGENUIT
Al nostro primo incontro con larte di Chagall proviamo un senso di familiarit mista a gaiezza e lieve malinconia.
Non abbiamo forse scoperto lartista-bambino, lardente narratore di fiabe popolari predestinato a diventare il nostro beniamino, il fanciullo cosmico di cui, nel 1921, scrive il poeta e critico Theodor Dubler nellappassionato omaggio apparso su Valori plastici? Al successivo incontro proviamo tuttavia sconcerto: laffabulatore magico, linventore di tipi e personaggi si rivela un artista meno ingenuo di quanto credevamo, in possesso di una grande variet di tecniche e stili, infinitamente prolifico e perdipi incline allallegoria e al mistero. Non appena il nostro sguardo si addentra nelle immagini, riconoscendo dettagli che a tutta prima ci erano sfuggiti e decifrando analogie, ecco che queste ci si mostrano in una luce arguta e bizzarra, dense di riferimenti alla storia dellarte e al dibattito contemporaneo.
Contiamo almeno quattro grandi periodi nella produzione di Chagall, ma le cesure tra periodo e periodo non sono semplici: lartista usa simultaneamente maniere diverse. Allapprendistato, che si svolge tra Vitebsk (la citt natale, nellodierna Bielorussia) e Pietroburgo fino al 1910, segue il primo periodo parigino, dal 1911 al 1914, caratterizzato dalla rapida (ma non pedissequa) assimilazione di procedimenti simultaneisti e cubisti.
A Vitebsk studia pittura da Yehuda Pen (1854-1937), modernista moderato impegnato nella creazione di una tradizione ebraica moderna e nella raffigurazione di tipi e scene di genere. Ma a Pietroburgo che si compie la sua iniziazione artistica e in senso lato culturale. Conosce Lon Bakst (1886-1924) e si trattiene per qualche tempo alla sua scuola. Il ricercato eclettismo dellillustre pittore e coreografo e il modernismo estetizzante di Mir Iskusstva (Il mondo dellarte) non fanno tuttavia per lui, che mostra un precoce interesse folklorico e dipinge immagini nel goffo stile umoristico dei pittori di osterie.
Chagall giunge a Parigi nellimminenza del successo di scandalo che arride ai nuovi orientamenti cubisti. Fa in tempo a visitare il Salon des Indpendants del 1911 e prende parte lui stesso ai Salons dellanno successivo. Nel frattempo stringe rapporti con pittori, critici e poeti suoi amici e mentori sono Blaise Cendrars (1887-1961), Guillaume Apollinaire (1880-1918), Robert Delaunay (1885-1941) e Ricciotto Canudo (1877-1923), questultimo tra i primi a riconoscere limportanza artistica del cinema ed estende la sua fama in Francia, Germania e Italia.
La partecipazione al primo Salone dautunno tedesco, che si tiene a Berlino nel 1913, e una successiva personale alla galleria Der Sturm gli assicurano ampio riconoscimento tra gli espressionisti tedeschi, in particolare tra gli artisti del Cavaliere azzurro, cui lo unisce lammirazione per larte infantile e popolare. Sempre nel segno del nativo e del vernacolare linteresse che Chagall desta in un futurista anomalo o precocemente estraneo agli eccessi sperimentali dellavanguardia prebellica, Carlo Carr (1881-1966). Almeno a partire dal 1916 proprio lartista russo spinge Carr a riscoprire i primitivi italiani in chiave antigraziosa, fiabesca e in apparenza maldestra.
Dal 1914 al 1922 di nuovo in Russia. Lo scoppio delle ostilit lo sorprende a Berlino, lontano dalla Francia: costretto a tornare in Russia e a risiedere a Vitebsk. Mette a punto un suo grande stile in larga parte scevro di elementi cubisti, intimo e monumentale al tempo stesso, con protagonisti lui stesso, la moglie Bella (sposata nel 1915), i tipi della comunit ebraica locale, le case tradizionali in legno colorato.
Proprio nel secondo periodo di Vitebsk, Chagall sviluppa con pi determinazione i temi identitari ebraici che lo caratterizzeranno in seguito. Reagisce alla propaganda antisemita che si diffonde in Russia negli anni della prima guerra mondiale approfondendo i vincoli affettivi e culturali che lo legano alle origini. Aderisce entusiasticamente alla Rivoluzione dottobre e al governo dei Soviet, che riconosce agli ebrei lo status di pieni cittadini, e assume responsabilit politico-culturali dirette. Commissario artistico, fonda e dirige la scuola darte di Vitebsk e, tra il 1919 e il 1920, vi chiama a insegnare artisti come Puni (1894-1956), El Lisickij (1890-1941), Malevi (1878-1935).
Rientrato a Parigi nel 1922, nel periodo tra le due guerre Chagall adotta uno stile ampio e colorato, lo stesso cui oggi pi facilmente associato. Temi fantastici intrecciati a osservazioni umoristiche e pungenti, divagazioni edeniche, motivi sacri. Lartista dispone ormai di un repertorio ampio e differenziato cui pu attingere nelle pi diverse occasioni guidato dalla rispondenza a circostanza e contesto. Acrobati, animali, villaggi russi, artisti e innamorati, storie bibliche. Chagall alterna limpegno grafico o pittorico allesplorazione di tecniche ornamentali come il mosaico, la ceramica o larte del vetro. Si dedica con uguale motivazione a progetti monumentali e allillustrazione di una fiaba. Il suo lavoro richiesto e apprezzato in tutto il mondo e il soggiorno americano negli anni della seconda guerra mondiale gli procura ulteriore fama e commissioni di grande prestigio. Progetta vetrate per la cattedrale di Metz, il Fraumnster di Zurigo, la sinagoga dellospedale di Hadassah a Gerusalemme e ancora per la cattedrale britannica di Chichester e il palazzo delle Nazioni unite a New York. Nel 1964 dipinge il soffitto dellOpra di Parigi su invito del ministro della cultura francese Andr Malraux e un anno pi tardi gli immensi murali dellatrio della Metropolitan Opera House di New York. Il suo nutrimento duplice: la storia del mito e della religione da un lato, la storia dellarte dallaltro.
La tradizione figurativa delle sinagoghe, geometrica o animalistica, la miniatura altomedievale (e in subordine la miniatura Moghul o persiana), i maestri italiani del Tre e del Quattrocento, Rembrandt, Henri Matisse e il Picasso blu, primitivista e mediterraneo sono interlocutori costanti di Chagall, pressoch in ogni momento della sua carriera: le immagini allestiscono un dialogo personale e versatile con maestri antichi e moderni, repertori classici e modelli desueti.
TRA PARIGI E LA RUSSIA
Larrivo a Parigi dirompente per il giovane artista neofolklorico.
Il confronto con gli orientamenti pi innovativi suscita in lui una reazione ambivalente: imitativa e al tempo stesso di rifiuto. A partire dal mercato dove, non avendo soldi, acquistavo soltanto un pezzettino di un lungo cetriolo, ricorda Chagall nellautobiografia La mia vita, loperaio nella sua tuta blu o i discepoli pi zelanti del cubismo, tutto [a Parigi] testimoniava di un gusto netto della misura, di chiarezza, di un senso preciso della forma, di una pittura pi accurata e finita, perfino nelle tele degli artisti di secondordine.
Non potremmo immaginare niente di pi dissimile dalle composizioni in stile popolare che Chagall ha dipinto a Vitebsk o a Pietroburgo delle tele cubiste che Metzinger o Lger, Gleizes o Delaunay, La Fresnaye o Fauconnier espongono tra il 1910 e il 1911 in gallerie private o ai Salons della capitale. Si tratta certamente di artisti molto diversi tra di loro, di diverso temperamento, tecnica e qualit. Sono tuttavia loro i cubisti riconosciuti, acclamati o vituperati, pronti a occupare presso il vasto pubblico il ruolo cui Braque e Picasso, che preferiscono non esporre, si sottraggono.