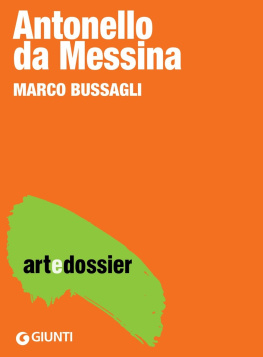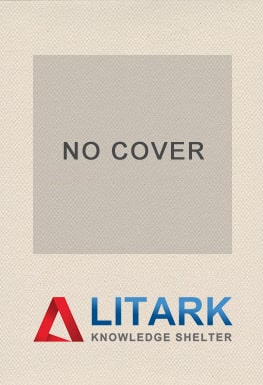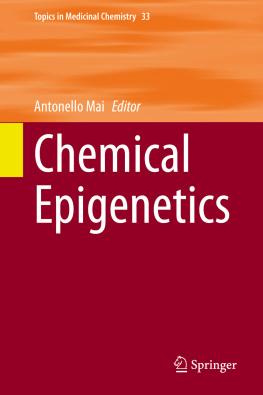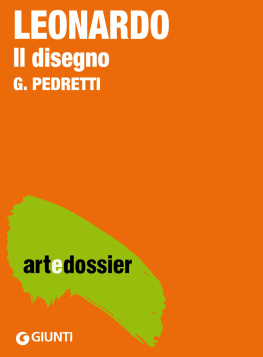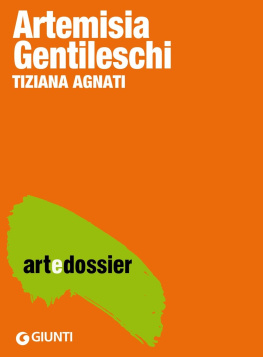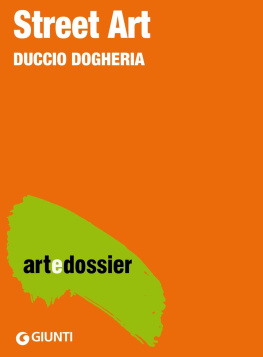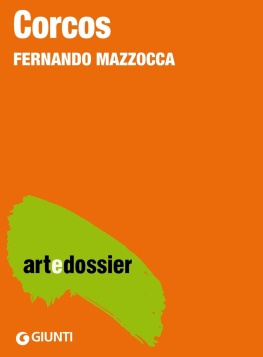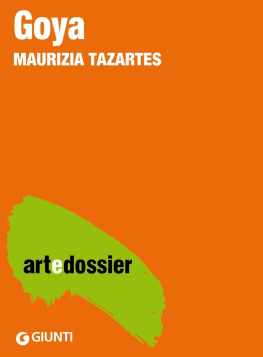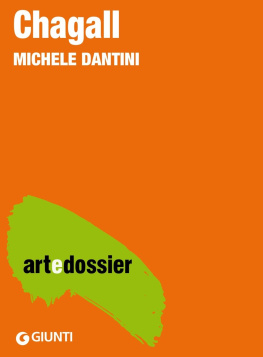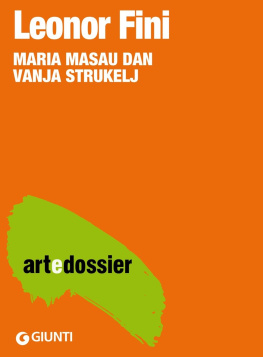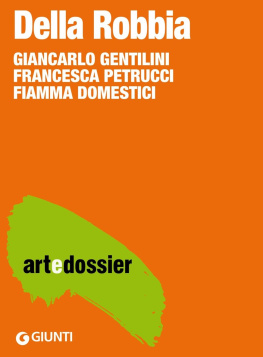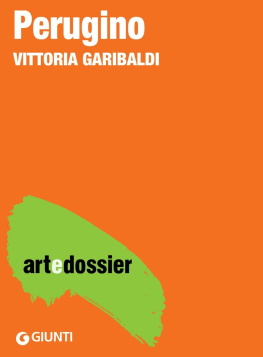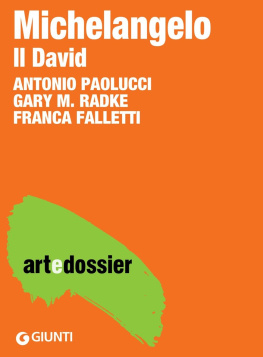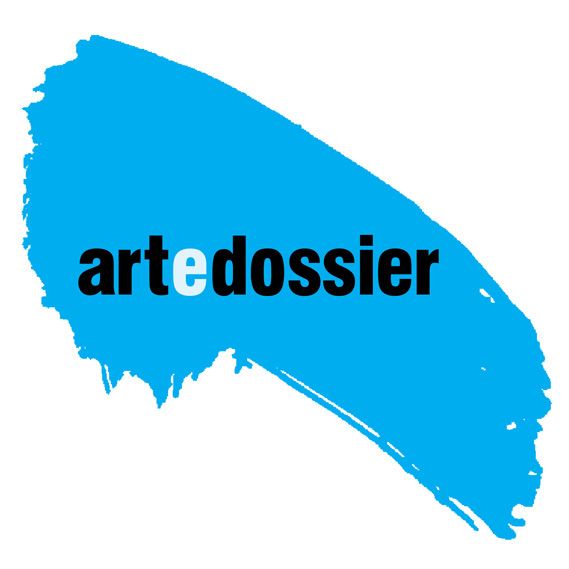2014 Giunti Editore S.p.A.
LA FORMAZIONE
Una delle attivit preferite degli storici dellarte sembra essere quella di sottolineare le inesattezze di Giorgio Vasari. Pare quasi che ci sia un gusto speciale nel segnare con la matita rossa e blu la celebre raccolta di biografie artistiche del grande pittore e critico aretino. Certo, gli sbagli vanno emendati e la prospettiva storica, se necessario, rettificata, ma mi pare ingeneroso non dar conto, nel contempo, dei meriti indubbi che lopera di Vasari ha avuto e continua ad avere per la conoscenza della storia dellarte del passato. Nonostante la grande messe di studi sullopera vasariana, c sempre qualche studioso che si picca di sottolineare le imprecisioni dellillustre aretino, senza ricordare che una buona parte delle notizie che possediamo ci vengono proprio dai suoi scritti. Non solo, ma anche quando si dimostra palesemente che Vasari ha sbagliato, in realt, siamo stati in grado di correggerne gli errori proprio grazie alle sue stesse indicazioni.
Un caso esemplare quello di Antonello da Messina. Nella breve biografia che le Vite ci tramandano, almeno la met dedicata alla rilevante novit che, secondo Vasari, Antonello avrebbe introdotto in Italia, ossia quella della tecnica dei colori a olio. La narrazione, in proporzione con lestensione del testo, piuttosto lunga e attribuisce linvenzione vera e propria della pittura a olio a Giovanni da Bruggia, vale a dire Jan van Eyck. La notizia non esatta, ma gi offre unindicazione sullambiente culturale con cui Antonello dovette avere a che fare. Bisogna sapere, infatti, che, a detta di Vasari, Giovanni da Bruggia avrebbe tramandato il proprio segreto a Ruggieri da Bruggia, ovvero Rogier van der Weyden che, a sua volta, lo avrebbe consegnato ad Ausse, suo discepolo, ossia Hans Memling. In realt, quasi certamente, il viaggio di Antonello in Fiandra non c mai stato, ma le indicazioni di Vasari circa la relazione con Napoli, il rapporto con la pittura e la cultura figurativa fiamminga sono quanto mai esatte e hanno permesso agli studiosi di orientarsi proficuamente nella ricostruzione degli esordi di quel sommo artista che Antonello da Messina.
Il grande passo in avanti nel tentativo di una corretta ricostruzione degli anni di formazione del grande artista messinese si deve a Francesco Nicolini che pubblic, nel 1925, lormai nota lettera del napoletano Pietro Summonte in risposta al veneziano Marco Antonio Michiel, interessato ad avere notizie sul pittore siciliano, documento nel quale si trovano anche indicazioni importanti circa il ruolo di un artista che, fino al momento della scoperta del Nicolini, era rimasto ai margini della critica moderna: Cola de Neapoli, meglio noto con il nome di Colantonio. Infatti, rispondendo al Michiel (che aveva labitudine di visitare le collezioni degli eruditi e dei nobili di Venezia per poi farne tesoro nel suo Notizia dopere del disegno), Summonte, in quel lontano 1524, precis qual era, artisticamente parlando, la situazione di Napoli nel momento in cui Antonello frequentava la citt partenopea. Queste le sue parole: Da questo tal tempo non havemo avuto in queste parti, n homo externo n paesano, celebre fino ad maestro Colantonio nostro napoletano, persona tanto disposta nellarte della pictura che, se non moriva iovene, era per far cose grandi. Costui non arriv, per colpa delli tempi, alla perfezione del disegno delle cose antique, s come ci arriv lo suo discepolo Antonello da Messina: homo secondo intendo, noto appresso voi. La professione di Colantonio tutta era si come portava quel tempo, in lavoro di Fiandra e lo colorire di quel paese; al che tanto era dedito che aveva deliberato dandarvi. Ma il re Raniero lo ritenne qui col mostrargli ipso la pratica e la tempera di tal colore. Pertanto, opinione comune che Antonello si sia recato a bottega da Colantonio fra il 1438 e il 1442, forse dunque gi prima dellavvento di Alfonso I dAragona e, a ogni modo, senzaltro prima del 1457, quando Antonello si trov impegnato nella realizzazione della sua prima opera documentata per Reggio Calabria.
Sulle origini anagrafiche di Antonello e della sua famiglia si ampiamente indagato, soprattutto da parte di studiosi come Gioacchino Di Marzo e Gaetano La Corte Callier i quali non solo hanno dimostrato che quella locale non affatto storia minore, ma sono anche riusciti a fornire una serie di dati oggettivi grazie ai quali la figura dellartista messinese ha preso una notevole consistenza storica. Nonostante questo enorme sforzo, la data di nascita di Antonello risulta ancora avvolta nelle nebbie, sicch la si colloca, in funzione di quella di morte (avvenuta fra il 14 e il 25 febbraio 1479), nel decennio che va dal 1420 al 1430, ma con maggior propensione per la seconda data, dal momento che Vasari afferma che si mor danni 49. Va da s, allora, che mantenere un figlio lontano da casa per farsi una professione doveva essere piuttosto oneroso e che senza una solida ricchezza alle spalle non sarebbe stato possibile.
Quanto alla forbice dei dieci anni entro i quali si colloca lipotetica data di nascita di Antonello, la conseguenza sullambiente artistico che egli dovette trovare a Napoli nel corso del suo apprendistato si riduce a poca cosa. vero, infatti, che se Antonello fosse nato verso il 1420, avrebbe potuto vedere una citt angioina, mentre se la sua nascita fosse avvenuta dieci anni pi tardi, ne avrebbe vissuta una aragonese, come ricorda Vasari, e di quellaltra avrebbe avuto solo il ricordo; nellun caso e nellaltro, per, lartista avrebbe comunque beneficiato dei rapporti con larte nordeuropea. A Napoli, Antonello dovette assorbire con grande avidit la lezione di Colantonio. Basta infatti esaminare alcune opere di questultimo per rendersi facilmente conto degli stretti legami formali e intellettuali che lo apparentano allartista messinese. La pi antica e, forse, la pi celebre opera di Colantonio il SanGirolamo nello studio conservato nella pinacoteca del museo di Capodimonte a Napoli, che mostra il santo in compagnia dellimmancabile leone che gli posa la grande zampa sulle ginocchia, come fosse un dolce cagnolino, per farsi togliere una spina, cosa che Girolamo fa assai amorevolmente. Lattenzione ai particolari e la precisa descrizione delle carte affastellate luna sullaltra nella stanza, insieme ad altri oggetti, come boccette e scatole ghiotte occasioni, per il pittore, di dimostrare tutta la sua abilit nel dipingere nature morte ante litteram , hanno convinto gli studiosi, confortati dalla citata lettera di Summonte, dellascendenza fiamminga dello stile del pittore napoletano, filtrata, per, attraverso lesperienza provenzale di un artista come il cosiddetto Maestro dellAnnunciazione di Aix. Infatti, sia i libri accatastati sul leggio posto accanto alla Vergine nellopera eponima di questo artista (la tavola nella chiesa della Maddalena di Aix), sia, soprattutto, i volumi del